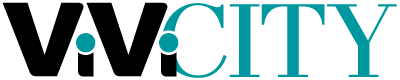Il ricordo di Mariangela Melato e del suo esordio. Al regista bolognese è stato attribuito il Premio alla Carriera
Il grande cinema irrompe al Tropea Film Festival con il regista Pupi Avati la produttrice di Febbre da cavallo Alessandra Infascelli e Luca Manfredi, figlio del celebre attore. La quinta giornata della kermesse ha visto i tre protagonisti raccontarsi e raccontare il cinema di ieri e di oggi al pubblico che ha affollato Palazzo Santa Chiara nel cuore storico di Tropea. Avati autore di grande respiro che, dal ’68 ad oggi ha girato oltre quaranta film, dal Tropea Film Festival, ha ricevuto il Premio alla Carriera, realizzato dal maestro orafo Michele Affidato. E’ toccato al regista aprire la serata raccontando impegnato a girare Thomas e gli indemoniati, anni settanta a Ferrara, ebbe modo di avviare la carriera della grande Mariangela Melato. Il set è una chiesa sconsacrata. L’attesa per l’avvenente attrice selezionata ai casting di Milano è grande, ma si presenta una ragazza molto diversa. Non era alta, non era bionda, né particolarmente attraente. Il maestro, deluso, le chiede di accomodarsi fuori. Lei esce dalla chiesa e si siede su un muretto. Resterà lì fino a sera quando, alla chiusura del set, il regista se la ritroverà davanti. Quella caparbia aspirante attrice era Mariangela Melato ed è stato così che il maestro impressionato dalla sua determinazione, le ha dato una chance: dal canto suo la donna è riuscita ad incantare l’intera troupe alla prima interpretazione.

«Il cinema è lo specchio di quello che siamo, di quello che siamo stati e di quello che potremo essere – ha asserito Pupi Avati – Ci osserva, ci racconta, ci critica come solo un maestro sa fare». Sul momento critico del settore: «Il cinema riflette in modo puntuale il Paese. Raccoglie quello che suggestiona ed esalta. Un mondo in cui la meritocrazia è diventata l’ultimo elemento per valutare una persona. Questa società produce privilegi, tanto che quando si apre la finestra su un’ipotesi di opportunità si pensa ad un amico».
Quindi Avati entra nel vivo di una delle piaghe che ha danneggiato e danneggia tutt’ora l’arte cinematografica. «Il mediocre vuole persone da controllare. C’è questa catena di incompetenza che ho constatato nell’arco di sessant’anni di cinema. Ho incontrato persone inadeguate al ruolo che avevano, che definisco ruffiani».
Quanto alla tensione sentimentale che lo ha spinto a raccontare la nostra società per decenni, Avati spiega il suo legame con l’humanitas di Roberto Rossellini. «Il tentativo di condividere emozioni, questa è la parte autentica. Io mi emoziono di fronte a una scoperta e con spirito rosselliniano avverto di volerla condividere con gli altri e lo faccio con il cinema e la scrittura. La missione di Rossellini è stata condividere una gioia, un’emozione. Un percorso che ho intrapreso molto tardi, perché ho vissuto i primi decenni della mia vita impegnato in un progetto musicale. Il giorno che ho lasciato la musica, quando ho scoperto che non disponevo del talento per fare il musicista, è stato doloroso. Una sera ho convocato alla fine di una prova i miei amici con cui condividevo quell’avventura per comunicare che smettevo di suonare, nessuno di loro ha detto di no. Nessuno ha insistito a farmi cambiare idea».
A proposito di talento, dopo l’amara riflessione il regista spiega il suo metodo. “Per capire se i giovani hanno talento devi metterli alla prova. Dandogli in mano un testo, facendoli cimentare in un monologo. Ognuno dispone di un talento. Ma quando replicano: tanto io ho un piano B, trovo una risposta scadente. Una volta non avevamo paura. Più i sogni sono grandi e improbabili e più è possibile che si avverino. Io vendevo il pesce surgelato, ero distante anni luce dal cinema. Come potevo immaginare che avrei fatto 54 film? La fortuna non ha ruolo in questa vicenda”.