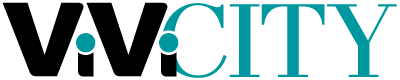La verità è che si tratta un colpo di maglio che prospetta un futuro di parcellizzazione, non solo finanziaria ma anche funzionale, ideologica ed addirittura identitaria
IL NODO dell’Autonomia differenziata sta diventando il vero centro del dibattito politico e sociale nel nostro Paese. Un nodo che preoccupa, soprattutto, i territori più fragili e che, secondo non pochi osservatori, pone a rischio l’unità effettiva della Nazione.
Il tutto nasce, come si sa, da tre proposte pervenute dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e dalla circostanza che, in data 23.1.2024, il Parlamento ha approvato il d.d.l. governativo con il quale si regolamenta il meccanismo di attuazione dell’art. 116 comma 3 della Costituzione, destinato a conferire alle Regioni che ne facciano richiesta forme speciali di autonomia.
Si proverà, in questa sede, a fare un punto esclusivamente giuridico della questione, ponendo sullo sfondo le questioni di necessaria coerenza istituzionale e costituzionale dell’intervento.

Per intendere la portata della questione serve ricostruire i passi che hanno condotto a tale stadio
Con legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001 è stata approvata una riforma che, nell’intesa di depotenziare il centralismo statuale disegnato dai Costituenti del 1948, ha riordinato l’intero titolo V della Costituzione e, cioè, il sistema di riparto dei poteri tra Stato e Regioni. In particolare, sono state rinforzate le prerogative di queste ultime, sia sul versante legislativo che su quello gestionale, nel contempo riducendo l’area delle funzioni spettanti allo Stato. Segno di quanto sopra è il novellato art. 117, il cui comma 4, ribaltando il principio di residualità prima incentrato sullo Stato, ha stabilito che Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione riservata dello Stato. Un cambio di visione radicale, che ha trovato espressione nella riduzione delle potestà esclusive assegnate allo Stato centrale (art. 117 comma 2) e nell’estensione della potestà legislativa concorrente delle Regioni, allargata a molte materie di estrema rilevanza: sicurezza nel lavoro, rapporti internazionali delle regioni, commercio con l’estero, tutela e sicurezza nel lavoro, istruzione, tutela della salute, ricerca scientifica, protezione civile, porti ed aeroporti civili, ordinamento della comunicazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, coordinamento della finanza pubblica e sistema tributario, casse di risparmio, previdenza previdenziale e complementare, etc. (art. 117 comma 3). Tutto questo mentre è scomparso un elemento unificante, la necessaria coesione della legislazione regionale “con l’interesse nazionale e con quello di altre regioni”, presente nel vecchio testo.
Tale dilatazione delle materie di competenza regionale ha avuto un corrispettivo nell’entità delle risorse conferite. Il nuovo art. 119 Cost. ha, infatti, previsto che I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa” (comma 1) e dispongono di risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio. (comma 2). Inevitabili le conseguenze: lievitazione dei livelli di tassazione globale, dispiegamento diseguale delle risorse, in favore delle regioni economicamente più forti; incremento dell’indebitamento complessivo del Sistema-Paese, parcellizzazione della normativa nelle materie devolute. In definitiva, la forbice tra le varie Regioni, piuttosto che sanarsi, è andata espandendosi, nonostante le norme perequative contenute nell’art. 119 comma 3, destinate ai “territori con minore capacità fiscale per abitante”, vanificate da un trucco contabile ancora in essere, la c.d. spesa storica, espressione elegante dietro la quale si annida e perpetua un metodo di intollerabile discriminazione ai danni dei territori più fragili.

La riforma del Titolo V ha contemplato un elemento ancora più insidioso per l’unità Nazionale.
Tuttavia, la riforma del Titolo V non si è fermata qui. Essa ha contemplato un elemento ancora più insidioso per l’unità Nazionale. Ha infatti previsto, con l’art. 116 comma 3, che Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. Una norma capace di erodere ulteriormente le prerogative dello Stato, con riferimento: 1) a materie di sua competenza legislativa esclusiva (art. 117 secondo comma), enumerate alle lettere l) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa), ancorchè limitatamente dall’organizzazione della giustizia di pace; n) (norme generali sull’istruzione) ed s) (tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali); 2) a tutte le materie destinate a legislazione concorrente (art. 117 comma 3), come sopra succintamente elencate. Il senso di tale disposizione corrisponderebbe, secondo i riformatori del 2001, alla necessità di valorizzare maggiormente i territori, accentuandone l’autosufficienza, la capacità di autodeterminazione e soprattutto, la specificità identitaria. Si tratta, in realtà, di un colpo ben assestato all’Unità della Nazione prefigurata dall’art. 5 della Costituzione, peraltro mai realmente conseguita, né dopo il 17.3.1861, giorno della proclamazione del Regno d’Italia, né dopo il 27.12.1947, giorno della approvazione della nuova Carta Costituzionale.
***
Le richieste di maggiore autonomia pervenute dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna si innestano in questo solco concettuale e sono riferite, sostanzialmente, a tutte le materie potenzialmente contendibili ex art. 116 comma 3 della Costituzione. Ne è seguito l’avvio di un percorso attuativo, che ha avuto espressione nel disegno di legge 8.11.2022 recante Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata di cui all’art. 116, terzo comma, della Costituzione, approvato con modificazioni dal Senato nella seduta del 23.1.2024. Trattasi di una norma a funzione complessa, per un verso direttamente attuativa dell’art. 116/3 della Costituzione, per altro verso costituente legge delega per le successive attività spettanti al Governo.
In premessa, in maniera formalmente corretta, il d.d.l. ha stabilito che condizione imprescindibile perché sia dato esito alle domande avanzate dalle Regioni è la fissazione dei LEP (Livelli essenziali delle prestazioni), in armonia a quanto prescrive l’art. 117 comma 2 lett. m) della Costituzione, che ne attribuisce la competenza esclusiva ad una legge dello Stato. Ha così previsto, all’art. 3 comma 2, che ogni “Intesa” con le regioni interessate va fatta precedere dalla definizione dei LEP, da adottarsi nel termine di 24 mesi, con appositi decreti legislativi dal Governo.

Come è possibile fare in 24 mesi ciò che non si era voluto o saputo fare in venti anni?
Qui un primo dubbio. Come è possibile immaginare di fare in 24 mesi ciò che non si era voluto o saputo fare nei due decenni precedenti? Ebbene, il d.d.l. ha provvisto l’iter di plurimi meccanismi acceleratori ai limiti, come si vedrà, della incostituzionalità.
Una prima volta, con l’art. 3 comma 2, in cui è possibile leggere che “gli schemi di ciascun decreto legislativo sono trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione”. Un termine palesemente insufficiente, considerata l’enorme quantità di dati funzionali, finanziari, prestazionali da prendere in esame, ovviato con una deroga per la quale, decorso il termine, “il decreto legislativo può essere comunque adottato”. In altri termini, la norma autorizza il Governo a saltare, dopo i 45 giorni, il passaggio parlamentare, ancorchè un istante prima prescritto come obbligatorio e, dunque vincolante o parzialmente vincolante.
Una seconda volta, con l’art. 3 comma 2, laddove si prevede, a proposito delle osservazioni del Governo circa il parere delle Commissioni competenti, che, ove queste ultime non si pronuncino nel termine di “venti giorni dall’assegnazione…il decreto legislativo può essere comunque emanato”.
Una terza volta, con l’art. 3 comma 7, in cui si prescrive che “Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza Unificata, da rendere entro venti giorni”, con la precisazione tuttavia che, decorsi detti termini, “gli stessi schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per profili finanziari”.
Una quarta volta, con lo stesso art. 3 comma 7, in cui si prescrive che, nell’ipotesi in cui le Commissioni Parlamentari competenti non dovessero rendere il parere loro richiesto “nel termine di trenta giorni”, i decreti potranno comunque “essere adottati”.
Definizione Lep: c’è da credere che tutti i termini verranno puntualmente mancati
In definitiva, grazie ad un modello che considera contendibili le prerogative del Parlamento e dei territori, il Governo potrà giungere all’adozione dei LEP: a) senza il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari (art. 3 comma 2); b) senza il parere di dette Commissioni riguardo alle osservazioni del Governo (art. 3 comma 2); c) senza il parere della Conferenza Unificata sugli schemi di decreto legislativo (art. 3 comma 7); d) senza il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sugli schemi di decreto (art. 3 comma 7).
C’è da credere, considerando la complessità della materia, che tutti i termini verranno puntualmente mancati e che, pertanto, si potrà arrivare alla definizione dei LEP senza i necessari pareri di Commissioni Parlamentari e Conferenza Unificata. Uno svuotamento istituzionale che solleva severi dubbi di incostituzionalità e configura un autentico conflitto di attribuzioni.
***
Tuttavia, il meccanismo di indebita accelerazione non riguarda solo il momento di approvazione dei LEP. Esso riguarda, anche, quello di formazione ed approvazione delle “Intese” con le Regioni. Ne fa testimonianza l’art. 2 comma 4 del testo approvato dal Senato, in cui è precisato che “Lo schema di intesa preliminare …è immediatamente trasmesso alla Conferenza Unificata…per l’espressione del parere, da rendere nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione”. Ebbene, in nome del medesimo principio, la norma proclama la rinunciabilità di detto parere e stabilisce che “Dopo che il parere è stato reso dalla Conferenza Unificata e comunque decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta Regionale. Detto altrimenti, lo schema di Intesa Preliminare potrà legittimamente giungere alle Camere senza il previo parere della Conferenza Unificata, ancorchè proclamato obbligatorio dalla stessa norma.
Ma v’è di più. Lo schema potrà divenire definitivo non solo in assenza del parere della Conferenza Unificata, ma anche degli “atti di indirizzo” del Parlamento. Infatti, il successivo comma 5, dopo aver asserito che “il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutato il parere della conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4… predispone lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario”, prevede che tale attività possa darsi “comunque decorso il termine di novanta giorni” dato al Parlamento. In definitiva, per decorrenza dei termini, sarà possibile prescindere, nella fase conclusiva dell’Intesa, così dal parere della Conferenza Unificata come agli atti di indirizzo del Parlamento. Ciò ancorchè la stessa norma avesse, per un verso, imposto di valutare il primo e, per altro verso, di fondare l’approvazione dello schema definitivo “sulla base” dei secondi. Peraltro, non si vede come Il Presidente del Consiglio o il Ministro competente possano predisporre lo schema definitivo in mancanza dei suoi necessari presupposti. Il dato è maggiormente saliente considerata la fonte dei due atti che, provenendo dal Parlamento e dalla Conferenza che rappresenta tutte le articolazioni della Repubblica, assume veste per un verso obbligatoria, per altro verso vincolante o, a tutto concedere, parzialmente vincolante.
***
E tuttavia, si pongono altre questioni, sul piano della coerenza istituzionale.
La prima. Un atto di così enorme rilevanza non viene affidato al Governo, nella sua dimensione collegiale, ma ad un organo monocratico, facoltativamente individuato nel Presidente del Consiglio o nel Ministro per gli affari regionali e le autonomie (art. 2 comma 5). E’ costituzionalmente sostenibile tutto ciò? La lettura ragionata del nostro sistema non lascia margine al dubbio ed induce a ritenere che tale opzione sia inappropriata. Si ricorda che oggetto del decidere è l’attuazione di una norma costituzionale e che traguardo del procedimento è la mutazione radicale degli assetti del Paese. In questo quadro, pensare di affidare ad un organo monocratico, addirittura ad un semplice ministro, lo schema di Intesa definitivo appare, francamente, una forzatura costituzionale.
La seconda. Essa riguarda, ancora, le prerogative del Parlamento. Dispone l’art. 2 comma 6 che Con lo schema di intesa definitivo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delibera un disegno di legge di approvazione dell’intesa, che vi è allegata. Alla seduta del Consiglio dei Ministri per l’esame dello schema di disegno di legge e dello schema di intesa definitivo partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata. Dunque, il Parlamento non viene investito nella pienezza delle sue funzioni, ma semplicemente per ratificare, mediante “approvazione”, l’Intesa approvata dall’Esecutivo e concordata con le Regioni. Un dato non solo contrastante con la disciplina costituzionale, che impone un intervento parlamentare pieno ed a maggioranza assoluta, ma anche profondamente umiliante per la sovranità del Parlamento.
La terza. E’ costituzionalmente legittimo che una legge ordinaria possa imporre al Parlamento come e cosa debba fare, riducendolo a funzioni quasi notarili, sia nella fase di espressione del parere (esautorazione dell’Aula e preposizione della sola Conferenza Unificata e delle Commissioni competenti per materia), sia in quella di approvazione definitiva, risolta a mera “approvazione dell’Intesa”? Dove è finita l’autodichìa delle Camere, fondamento della nostra democrazia? Può una legge ordinaria travolgerne i Regolamenti, unica ed irriducibile fonte di funzionamento delle stesse? Tutto questo, si aggiunge, in spregio anche all’art. 116 comma 3 che, ripudiando il principio della mera “approvazione”, pretende che La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Ma v’è di più: cosa accade se, una volta licenziata dalla Regione interessata, nel termine di quarantacinque giorni il Consiglio dei Ministri non approvi l’Intesa definitiva e, con essa, il correlativo disegno di legge (art. 2 commi 5 e 6)? Trattasi di termine perentorio ovvero ordinatorio? Il silenzio del Consiglio dei Ministri va inteso, tecnicamente, come rifiuto, con conseguente arresto dell’intero iter, o come mero ritardo? E con quali conseguenze? La gestione dei termini, osservata nelle disposizioni precedenti, non lascerebbe dubbio circa la sua natura perentoria. Tuttavia, un chiarimento testuale sarebbe opportuno.
Lettura del Ddl con riferimento alla tecnica redazionale ed al merito della vicenda
Il d.d.l. approvato dal Senato il 23.1.2024 merita ulteriori chiavi di lettura, con riferimento alla tecnica redazionale ed al merito della vicenda.
Il d.d.l. precisa, all’art. 2 comma 2, che L’atto o gli atti d’iniziativa di ciascuna Regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni, senza fissazione, dunque, di alcun limite quantitativo o qualitativo. La platea delle materie contendibili, dunque, è assoluta e riguarda così quelle di competenza esclusiva dello Stato (art. 117 comma 2 lett.l), n), ed s) individuate dall’art. 116 comma 3, come quelle a legislazione concorrente (art. 117 comma 3). Né è previsto un approccio per transizioni successive, in modo da favorire l’assestamento e la verifica degli equilibri istituzionali incisi.
Ebbene, questo metodo non appare coerente con il principio di salvaguardia dell’Unità Nazionale (art. 5 ed art. 117 Cost.) e, soprattutto, impone effetti istituzionali e di assetto da cui, nonostante languide previsioni di monitoraggio (art.8) e di durata (art. 7), non sarebbe possibile tornare indietro. Detto diversamente, la norma, ad evitare scosse sulla tenuta del Sistema-Paese, dovrebbe prevedere un criterio di gradualità ed imporre che le forme speciali di autonomia non possano mai essere totalizzanti, ma avere un andamento progressivo, in modo che se ne possano monitorare gli impatti, sia verso lo Stato Centrale, sia verso le Regioni interessate, sia verso le altre Regioni, in un’ottica di necessaria coesione nazionale e solidale.
Sarebbe abbastanza per dubitare della coerenza del testo licenziato dal Senato
Purtroppo, c’è dell’altro. A dettagliare che trattasi di una riforma non solidale, ma spinta da fattori territoriali e differenziali, l’art. 3 comma 2 punto b) del ddl precisa che i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), premessa imprescindibile per dar luogo al trasferimento di funzioni (art. 3 comma 1), se non pervenuti entro ventiquattro mesi, potranno di fatto essere elusi. L’art. 3 comma 9 sul punto precisa che “Nelle more dell’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l’art. 1 commi da 791 a 801 bis, della legge 29 dicembre 2022 n. 197”. Ed ancora: “E’ fatta salva la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, svolta ai sensi dell’art. 1 commi da 791 a 801 bis della legge 29 dicembre 2022 n. 197, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo”. Le norme richiamate erano contenute nella legge di bilancio 2023 e prevedevano la definizione dei LEP e dei fabbisogni standard nel termine di 24 mesi, senza tuttavia alcuna investitura del Parlamento (art. 1 commi 795 e 796 l. 197/2022). Ebbene, l’idea che i LEP potranno trovare realizzazione per atti esclusivamente governativi fa tremare. In ogni caso, ad oggi, non se ne ha notizia, con la conseguenza che continua a trovare applicazione il principio – gravemente discriminatorio verso i territori più fragili – della c.d. spesa storica. Senza dire che detta modalità risulta altresì collidere con quella dei fabbisogni standard, introdotta dall’art. 1 dlgs 42/2009 allo scopo di sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica.
Del resto, c’è un ulteriore argomento a rendere insidioso il d.d.l. licenziato dal Senato. E’ del tutto evidente che la devoluzione di competenze aggiuntive alle regioni implica una omologa devoluzione di risorse. Il che comporterà un incremento inevitabile della spesa pubblica globale, uno svuotamento del bilancio dello Stato ed un arricchimento corrispettivo di quello delle Regioni interessate. In questo quadro, sfuggono i vincoli solidali posti dall’art. 119 Cost., che imporrebbero interventi additivi in favore dei territori più fragili. C’è da chiedersi: con quali risorse? Né è credibile il principio di invarianza fissato dall’art. 9 comma 1: Dall’applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’obiettivo è smentito dalla serie storica, per la quale, a fronte di maggiori competenze devolute alle regioni, si è sempre registrato un incremento più che proporzionale dei costi generali. E’ parimenti smentito dall’art. 5 comma 2, a mente del quale L’intesa di cui all’articolo 2 individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell’art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto previsto dall’art. 119, quarto comma, della Costituzione, disposizioni largamente eluse nei decenni precedenti.
Sommando il criterio della spesa storica, con quello dell’aumento esponenziale dei costi di decentramento e quello della compartecipazione ai gettiti erariali, il principio di invarianza appare non più che una elegante petizione di principio, mentre appaiono elevate le ragioni di rischio per la tenuta contabile e sociale del sistema-paese. In questa ottica, nemmeno è sostenibile la successiva annotazione, contenuta nell’art. 10 comma 3, secondo cui “E’ comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità finanziaria per abitante”. Ancora una volta, con quali risorse?
***
La verità è che l’autonomia differenziata è un colpo di maglio alla già tremula Unità della Nazione e prospetta un futuro di parcellizzazione, non solo finanziaria ma anche funzionale, ideologica ed addirittura identitaria del Paese, soprattutto in settori strategici come l’istruzione, l’energia, la sanità ed il lavoro. La libertà di scelta del luogo di lavoro, del luogo di cure, l’unità della contrattazione collettiva, l’omogeneità dell’offerta formativa e degli standard di istruzione saranno messi a gravissimo rischio, più di quanto già accade oggi, nel silenzio assordante delle istituzioni.
Il tema va ripensato e qualunque ipotesi di miglioramento del testo, a costituzione invariata, non basterà
Per concludere. Credo che il tema vada profondamente ripensato e che qualunque ipotesi di miglioramento del testo, a costituzione invariata, non potrà bastare. Il mio pensiero, in realtà, va in direzione ostinata e contraria, come direbbe il grande Fabrizio De Andrè. Credo serva al Paese un passo indietro, che porti ad un fermo ripensamento della riforma del 2001 e restituisca, certo con la necessaria appropriatezza, una nuova centralità allo Stato, attraverso: a) il recupero di molte delle materie devolute alla competenza legislativa concorrente delle Regioni (es. salute, istruzione, università, ricerca scientifica e tecnologica, lavoro, beni culturali, tutela dell’ambiente, rifiuti); b) la ricostituzione della primazìa dell’interesse nazionale, anche nelle materie assegnate alla competenza delle Regioni. Un processo di controriforma costituzionale rispetto a quella disadorna del 2001, che farebbe bene a tutti i territori, anche a quelli che oggi fanno il verso alla deriva federalista.
Serve, inoltre, espungere integralmente l’art. 116 comma 3 della Costituzione, irragionevole in una Nazione dalle dimensioni territoriali non tali da giustificare 20 micro-stati. Quantomeno, servirà emendarlo fermamente, in primis imponendo una più stringente causale differenziale, con decisa riduzione delle materie passibili di concordato, quindi prescrivendo una approvazione finale dell’Intesa con legge costituzionale. Altro che l’esangue ruolo notarile assegnato al Parlamento dal decreto legislativo licenziato dal Senato.
Fuori da tale prospettiva, c’è il rischio di un pericoloso ritorno alle frammentazioni ed ai frantumi del passato, che nulla hanno a che fare con i principi sovrani evocati dai padri costituenti, l’unità della Nazione, la solidarietà tra territori, la comune identità.